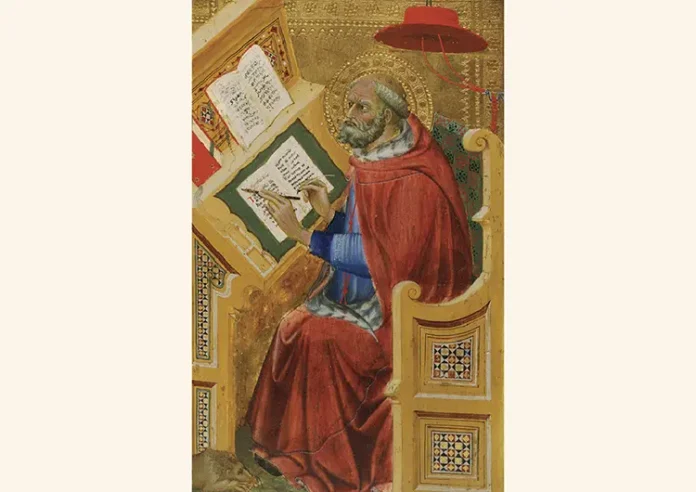L’ingiustizia può penetrare persino negli ambiti più insospettabili della cultura umana. La prova è che si è infiltrata nei proverbi, come ben esemplifica l’adagio italiano «Traduttore, traditore». Ma, nonostante l’offesa che lancia all’onorevole professione, questo aforisma contiene un suo fondo di verità.
Chi non considererebbe un tradimento tradurre saudade con añoranza, longing, regret o rimpianto? Le sfumature che rendono questa parola portoghese così espressiva traspaiono attraverso queste traduzioni così come la luce attraverso un vetro smerigliato: prive di chiarezza, confuse e sbiadite.
Una traduzione impossibile
Per attenuare questa conseguenza del peccato di Babele (cfr. Gn 11, 7-9), il traduttore che non voglia essere un traditore deve conoscere perfettamente la lingua che interpreta e quella verso cui traduce. Questo vale tanto per ciò che riguarda la grammatica, la sintassi o la semantica, quanto per i proverbi tipici, le sfumature di ogni espressione, le interiezioni, le metafore, l’ironia, l’ordine delle parole, i sottintesi… tutto ciò, insomma, che costituisce l’eloquenza di un popolo.
Ma non è tutto. È suo dovere conoscere a fondo l’opera in questione e, più di ogni altra cosa, l’autore: le sue convinzioni e intenzioni, la sua personalità e i suoi modi di dire, di essere e di intendere, il suo contesto storico, la sua vita, le sue esperienze. Prima ancora del libro, è necessario capire chi l’ha composto.
La traduzione fedele della Bibbia era un compito quasi impossibile, ma ci fu un uomo che riuscì a portarla a termine: San Girolamo
Il lettore immagini ora un’opera impossibile, o quasi, da tradurre in un’altra lingua: un libro scritto in lingue diverse – magari con grammatiche e alfabeti diversi – e variegato nei suoi stili letterari; elaborato nel corso dei secoli per popoli di tutte le epoche; dotato di un significato sia letterale che allegorico; nel quale non ci sia alcuna parola in più o in meno; il cui autore, o meglio i cui autori, siano conosciuti quasi esclusivamente attraverso quest’opera e che non siano stati nient’altro che “penne” di un unico Autore capace di tanta varietà. Ci sarà stato qualcuno abbastanza coraggioso da intraprendere una traduzione del genere?
Sì, il suo nome era Girolamo. E questo libro è la Sacra Bibbia.
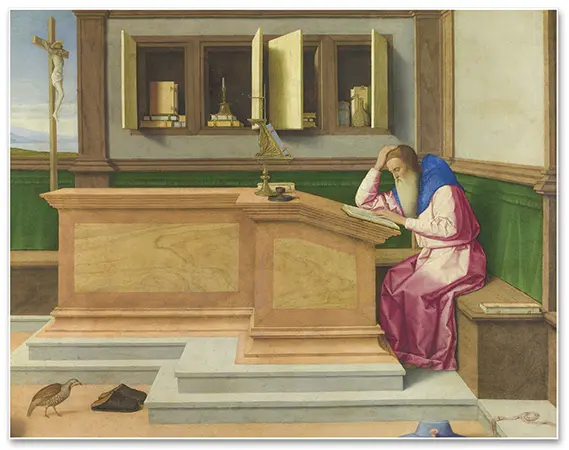
Preparazione involontaria
San Girolamo riuniva in sé tutte le qualità menzionate per portare a termine una missione così rischiosa: dal punto di vista umano, la padronanza del latino, del greco, del siriaco e dell’ebraico, oltre che della letteratura e dell’esegesi; dal lato spirituale, la santità per comprendere in modo ortodosso le pagine sacre, punto indispensabile perché intende Dio solo colui che Lo ama. Come, dunque, il Divin Ispiratore delle Scritture avrà preparato il suo interprete?
Nato nel 347 da una ricca famiglia di origine greca, a Stridone – frontiera dell’Impero Romano e crocevia di popoli, lingue e culture –, è inviato ancor giovane a studiare nell’Urbe. Lì, per quattro anni, frequenta le lezioni di grammatica, retorica e letteratura del famoso Elio Donato, considerato il miglior maestro di allora. Si distingue dai colleghi per la sua capacità intellettuale, la memoria prodigiosa e la dedizione alle lettere romane, che si tradusse nell’organizzazione di una enorme biblioteca personale. I primi strumenti per la sua missione erano stati conquistati: il latino, la letteratura e l’erudizione.
Se da questo punto di vista contrasta con i suoi compagni, quanto ai costumi è identico a loro: non ancora battezzato – era il tempo in cui gli uomini ricevevano le acque rigeneratrici da adulti – con denaro e amicizie licenziose, senza parenti che lo frenassero, Girolamo conduce una vita corrispondente alla proverbiale corruzione di Roma. Per poco tempo, però…
L’editto del 17 giugno del 362 promulgato da Giuliano l’Apostata toglieva ai cattolici alcuni diritti. Ma ciò che il cesare non aveva previsto era che uno studente si sarebbe servito di questo inizio di persecuzione per affermare la sua fede: Girolamo, con l’ardore della giovinezza e del temperamento, si iscrive tra i catecumeni per essere battezzato tre anni dopo da Papa Liberio. Da quel momento in poi sarà un cattolico nel senso più completo del termine; quello che oggi si direbbe un “fanatico”… Terminati gli studi, decide di intraprendere la via religiosa: parte a piedi per l’Oriente, desideroso del deserto. Nella primavera del 375 arriva in una comunità cenobitica nella Calcide dove trascorre due anni tra penitenze, tentazioni, malattie e slanci d’amore per Dio. Conquista così un altro elemento indispensabile per la sua vocazione: la santità.
Per sfuggire alle seduzioni della carne che lo assalgono continuamente nel suo ritiro, passa il tempo a imparare l’ebraico da un ebreo convertito. Poco dopo, lascia l’ascetismo e, ordinato presbitero ad Antiochia, stesso luogo in cui aveva seguito lezioni di esegesi, parte per il Concilio di Costantinopoli nel 381. Lì perfeziona con estrema rapidità i rudimenti di greco che possedeva e le sue già solide basi esegetiche. Due passi verso il compimento del disegno divino: disinvoltura in altre due delle lingue delle Sacre Scritture – gli sarebbe mancato per sempre un perfetto aramaico – e l’arte di interpretarle.
Una missione rischiosa
Il menzionato concilio bizantino ne precedette di poco un altro tenutosi a Roma. All’apertura delle sessioni, vediamo che a redigere i verbali, in qualità di segretario papale, è proprio lui… Sì, Girolamo di Stridone, che poco prima era un monaco del deserto! Accompagnando il suo Vescovo nella Città Eterna, fu aggregato ai servizi in Laterano perché considerato un cristiano expert – una rarità! – nelle lingue bibliche. Accanto a queste funzioni, scrive e traduce abbondantemente, senza mai abbandonare gli studi.

San Damaso, Sommo Pontefice di quegli anni, intuendo una speciale vocazione nel giovane segretario, testa le sue capacità: gli chiede di spiegare il significato del termine Osanna e di risolvere altre questioni bibliche. Le risposte arrivano così rapide e brillanti – accompagnate anche da un trattato contro l’eretico Elvidio e dalla traduzione di varie opere esegetiche di Origene – che il Papa osa rimuovere dalle sue preoccupazioni un problema che era presente da molti anni: la traduzione del Nuovo Testamento.
Mentre era segretario papale, Girolamo ricevette da San Damaso l’incombenza di tradurre il Nuovo Testamento in latino
All’epoca, nel mondo cattolico circolavano molteplici traduzioni latine delle pagine sacre: contraddittorie, lacunose, povere, erano «tante le versioni quanti erano i manoscritti».1 Si trattava della cosiddetta Vetus Latina. La soluzione risiedeva in una revisione intrapresa da una sola testa. E questa testa non poteva che essere quella di Girolamo. Giunto a questa conclusione, San Damaso nel 383 chiede al suo segretario la traduzione del Nuovo Testamento. La lentezza non aveva mai caratterizzato quest’uomo che, in un lavoro la cui rapidità ancora oggi stupisce, nel 384 consegna al Papa una versione latina dei Vangeli da lui tradotta sulla base di testi greci attendibili.
Nonostante il sostegno del Santo Padre, l’opera fu attaccata da ogni parte. Si parlava di mancanza di rispetto per le antiche edizioni. Ma Girolamo, sostenuto dal Pastore dei pastori, non temeva nulla; a tal punto che scriveva apertamente contro la vita dissoluta dei chierici e dei monaci romani. Non temeva nulla… fino al giorno della morte di San Damaso. La persecuzione che si scatenò contro di lui lo costrinse a tornare in Oriente nel 385. Da allora avrebbe vissuto a Betlemme.
La vocazione o il mondo
Nel suo nuovo domicilio, San Girolamo continuò a dedicarsi alla revisione dei testi biblici latini. Il suo obiettivo era ora quello di tradurre l’intero Antico Testamento nella lingua di Virgilio. Il lavoro era più esteso, ma sembrava meno difficile. Infatti, la versione greca dei Settanta – la Septuaginta – a partire dalla quale si sarebbe proceduto alla traduzione, era un testo estremamente affidabile, il più utilizzato dalla Chiesa primitiva, il più rispettato, quasi sacro. Non ci sarebbero stati grossi ostacoli.
Il nostro santo biblista svolgeva il suo compito maneggiando l’Hexapla di Origene,2 che metteva a confronto le versioni più autorevoli dell’Antico Testamento. Ma, man mano che procedeva, si accorgeva di non poche divergenze tra la Septuaginta e l’Ebraica. Non si preoccupò tuttavia al punto da lasciare la famosa versione greca, limitandosi ad alcune correzioni. Stava volando verso la conclusione del suo lavoro e solo un grave evento avrebbe potuto fermarlo. E fu esattamente un grave evento che si verificò: una mattina il traduttore si accorse che le pagine contenenti il frutto di quattro anni di sforzi – tra il 386 e il 390 – erano scomparse.3
Il Santo biblista decise di compiere l’eroico gesto di basarsi unicamente sugli “originali” ebraici, e le sue traduzioni finirono per soppiantare gli antichi testi latini
Vedendo in questo un segno divino, lasciò la Versione dei Settanta solo come un supporto e si decise all’eroismo di basarsi unicamente sugli “originali” ebraici. Eroismo? Sì, perché sapeva che mezzo mondo, o un mondo e mezzo, si sarebbe sollevato contro di lui: aveva già rifiutato i testi tradizionali latini e ora avrebbe “mancato di rispetto” alla tanto venerabile Bibbia dei Settanta… Agli occhi dei suoi contemporanei, era quasi un sacrilegio.

A dispetto della disapprovazione generale, il traduttore intraprese quella che sapeva essere la sua vocazione: nel 392 terminò il Salterio e i Profeti, entro il 396 i libri storici – con l’eccezione dei Giudici, rivisti fino al 400 – e quello di Giobbe, nel 400 i libri sapienziali e il Pentateuco. Tra il 404 e il 405 avrebbe concluso i deuterocanonici, come trasportato sulle ali: avrebbe tradotto il Libro di Tobia in un giorno e quello di Giuditta in una notte. Questo insieme di traduzioni iniziò a soppiantare gli antichi testi latini e, a causa della sua ampia divulgazione, venne conosciuto come Vulgata.
Così, nonostante lo scarso riconoscimento umano della sua opera, lo Stridonense lasciava eccellentemente tradotta tutta la Scrittura. Le generazioni successive lo avrebbero ringraziato, e a ragione. Con la “verità ebraica”, San Girolamo restituì ai cristiani diverse profezie messianiche che non si percepivano nella versione greca, da questa eliminò alcune ambiguità e mise a tacere lo scherno degli ebrei che ridevano delle traduzioni cristiane.4 Aggiungiamo che, contrariamente a molte versioni precedenti, la Vulgata non traduce i passi biblici parola per parola. Inoltre, trasposta in latino con il talento letterario degno di un Cicerone, il suo testo era di lettura piacevole per le orecchie sempre sensibili dei romani. Ricordiamoci che personaggi come Sant’Agostino, e lo stesso San Girolamo, tardarono a trovare il gusto per le Sacre Scritture proprio a causa di questo dettaglio stilistico.5
Da Girolamo fino a noi
Conseguenza: i fedeli si approssimarono ai prati sempre verdeggianti della Rivelazione. Il testo della Vulgata fu il più copiato della Storia e uno dei preferiti dalla stampa specializzata: la sua enorme diffusione è una realtà accecante.6 Diffusa in ogni angolo della terra, nel Medioevo divenne il grande libro di stile e d’ispirazione per scrittori, eruditi e saggi.
Soprannominato “Vulgata”, il testo di San Girolamo si diffuse in tutto il mondo ed è su questa versione della Bibbia che la Chiesa ha consolidato la sua dottrina
Ma più di ogni altra cosa, fu la versione su cui la Santa Chiesa consolidò la sua dottrina, per mezzo dei concili. Uno dei decreti di Trento dichiara che «l’antica edizione della Vulgata, approvata dalla Chiesa e già in uso secolare, è da considerarsi autentica […] e che nessuno, per nessuna ragione, può avere l’audacia o la presunzione di rifiutarla».7 A questa seguirà una revisione critica, la Nuova Vulgata, promulgata nel 1979 nella Costituzione Apostolica Scripturarum thesaurus e utilizzata dalla Chiesa latina nella Liturgia e nei documenti ufficiali.

La maggior parte delle versioni vernacolari, inoltre, fu elaborata a partire dal lavoro di San Girolamo. Così la Sposa Mistica di Cristo ascolta la voce del suo Dio a partire da questa traduzione, con essa in mano confuta gli eretici e, leggendola, istruisce i suoi figli. Probabilmente è la Bibbia che il lettore ha in casa…
Un tradimento?
Infine, la domanda dolorosa: se il traduttore è di solito un traditore, non sarà che la Vulgata tradisce il Divino Ispiratore dei testi sacri? Se nelle Scritture persino la «struttura stessa delle parole implica un mistero»8 e «la verità del dogma talvolta si decide a partire da una sola sillaba»,9 come possiamo supporre che una traduzione giustifichi tutte le interpretazioni che duemila anni di esegesi non sono ancora riuscite a esaurire? Non avrà forse San Girolamo ridotto alla fallibilità umana l’infinita grandezza della Rivelazione di Dio?
Al contrario, l’asceta di Betlemme ha conferito sicurezza alla debolezza umana concedendole una versione affidabile delle Scritture, e ha portato in tutto il mondo, senza uscire dalla sua cella, il seme della Parola Sacra che sarebbe fiorito in omelie, meditazioni e preghiere di tanti uomini e donne.
L’indiscutibile autorità della Vulgata deriva da un titolo del suo autore. Non quello di erudito, esegeta o linguista, né quello di biblista, traduttore o letterato, ma quello che abbiamo citato prima del nome di Girolamo: Santo. Soprattutto, gli valse il rispetto delle generazioni il fatto che la Santa Chiesa, sempre assistita dallo Spirito Santo, l’abbia assunta come propria. L’umanità riposa serenamente sulle pagine sacre, perché sa che tutti potrebbero tradire Dio, tranne un Santo… e, meno ancora, la sua stessa Sposa Mistica. ◊
Note
1 SAN GIROLAMO. Prólogo a los Libros de Josué y de Jueces. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 2002, vol.II, p.467.
2 Composta da Origene tra il 228 e il 240, è la più importante opera di critica testuale dell’Antichità cristiana, che confrontava in sei colonne parallele il testo della Septuaginta con il testo ebraico e con altre versioni greche dell’Antico Testamento. Girolamo utilizzò specialmente la quinta colonna, che presentava la Versione dei Settanta (cfr. HEXAPLA. In: HERIBAN, Jozef. Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliari. Roma: LAS, 2005, pp.473-474).
3 Cfr. BERNET, Anne. Saint Jérôme. Étampes: Clovis, 2002, p.345.
4 Cfr. CARBAJOSA, Ignacio: “Hebraica versus Septuaginta auctoritatem”. Existe un texto canónico del Antiguo Testamento? Estella: Verbo Divino, 2021, pp.43-53.
5 Cfr. SANT’AGOSTINO. Confessioni. L.3, c.5, n.9.
6 Cfr. BERZOSA, Alfonso Ropero. Versiones latinas. In: Gran diccionario enciclopédico de la Biblia. 7.ed. Barcelona: Clie, 2021, p.2603.
7 DH 1506.
8 SAN GIROLAMO. Epistola LVII, n.5. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 2013, vol.Xa, p.569.
9 DH 2711.