Non credo che il lettore si sia mai fermato a contare quante volte in un giorno sente o dice «grazie mille», anche in un mondo in cui questa espressione è sempre meno usata. Non credo neppure di essere stato il primo ad aver fatto risuonare nelle sue orecchie una formula così suggestiva.
Tuttavia, come spesso accade con quello che facciamo quotidianamente, l’uso di questa formula si è notevolmente logorato e il suo significato più profondo è ormai sconosciuto a quasi tutti coloro che la utilizzano nella vita di tutti i giorni. Assueta vilescunt…
Alcuni vedono il «grazie mille» semplicemente come un membro di quella famiglia la cui matriarca è la nobile signora delle “buona educazione”, i cui fratelli sono l’aristocratico «per favore» e il gentile «mi scusi», e i cui cugini sono tutte le famose “paroline magiche” che si imparano da bambini.
Ma in realtà, dietro queste due parole apparentemente anodine, si nascondono lezioni preziose su questo atto, allo stesso tempo comune e raro, semplice e bellissimo che è quello di ringraziare.
In ogni lingua, una sfumatura diversa
I popoli di lingua inglese esprimono la loro gratitudine attraverso il thank you, e la formulazione tedesca non è molto diversa: vielen Dank. Gli italiani dicono grazie e gli spagnoli gracias, entrambi influenzati dal latino: gratias ago. I francesi preferiscono il merci beaucoup; gli arabi, lo shukran jazylan; i giapponesi, invece, optano per il simpatico e austero arigatô.
È vero che tutte queste formulazioni hanno lo stesso scopo: ringraziare. In ogni lingua, però, il modo di farlo possiede una propria sfumatura.
San Tommaso d’Aquino spiega che la virtù della gratitudine comporta tre gradi: «Il primo è che l’uomo riconosca il beneficio ricevuto; il secondo consiste nella lode e nell’azione di grazie; il terzo consiste nel prestare la retribuzione nel luogo appropriato e al momento opportuno, secondo i mezzi di ciascuno». 1
Naturalmente non è necessario ricorrere a tutti e tre questi elementi contemporaneamente; spetta all’uomo prudente decidere, in base alle circostanze, se uno risulta sufficiente o se è necessario metterli in pratica tutti e tre.
Forse è per questo che nessuna delle lingue citate esprime simultaneamente tutti e tre i gradi di gratitudine. Ognuna, a suo modo, si riferisce a uno di essi.
Primo passo della gratitudine: un esercizio di memoria
Riconoscere. È ciò che cerca di fare il thank you: nella lingua inglese to thank – ringraziare – e to think – pensare – sono, etimologicamente, la stessa parola. E così accade anche in tedesco: zu danken – ringraziare – deriva da zu denken – pensare. Questo è il primo grado di gratitudine. Infatti, non si può ringraziare un benefattore senza considerare, senza riconoscere o senza pensare al beneficio che ci ha fatto.
Questo riconoscimento deve essere presente, soprattutto, nel nostro rapporto con il Signore. San Tommaso afferma che, per adempiere perfettamente al Comandamento di amare Dio sopra ogni cosa, la prima condizione è quella di «conservare il ricordo dei benefici divini».2
Si vede, allora, che quando si aspira ad acquisire la virtù della gratitudine, bisogna cominciare con l’esercitare bene la memoria… È chiaro: chi non si ricorda del proprio benefattore, non ringrazia; e chi non ringrazia, dice Sant’Agostino,3 perde anche quello che ha.
A volte non è sufficiente riconoscere
La forma di ringraziamento di una gran parte delle lingue latine si situa nel secondo grado elencato da San Tommaso: l’azione di grazie. Ne sono esempi il latino stesso – gratias ago –, lo spagnolo – gracias –, l’italiano – grazie – e il francese – merci.4 Anche l’espressione araba shukran jazylan si riferisce all’azione di grazie.
In buona parte dei casi, non basta solo riconoscere interiormente il beneficio che si riceve; è giusto e persino indispensabile esprimere la nostra gioia a chi ci ha fatto un bene, anzi, si tratta di un dovere di educazione. A volte, però, non c’è nemmeno bisogno di farlo a parole: la semplice dimostrazione di gioia costituisce già un ringraziamento.
Questo avviene, soprattutto, nel nostro rapporto con Dio. Di singolare bellezza è il confronto fatto dal Dott. Plinio Corrêa de Oliveira a questo proposito: «L’acqua di una fontana che colpisce il suolo e poi schizza verso l’alto in una serie di gocce è, anch’essa, simbolo della gratitudine del beneficiario su cui ricadono i favori celesti e che lancia verso l’alto, di nuovo verso il Cielo, la sua filiale e giubilante azione di grazie».5
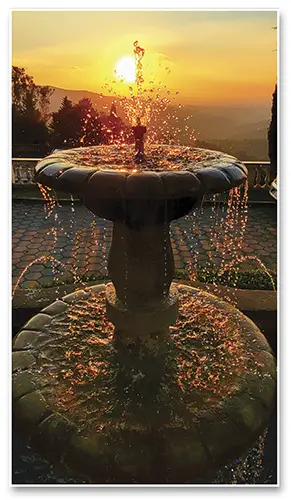
Fontana – Mairiporã (Brasile)
Al contrario, spiega San Bernardo,6 quando siamo ingrati verso il nostro Divin Benefattore, Egli potrà considerare perduto il favore che ci ha fatto e difficilmente tornerà a concedercelo, per non sprecare i tesori della sua Provvidenza.
Un obbligo che viene assunto spontaneamente
Infine, arriviamo al tanto amato «muito obrigado» portoghese. Cosa sta a significare questa espressione? Vogliamo forse dimostrare al nostro benefattore che non abbiamo apprezzato il suo dono e che siamo stati “obbligati” ad accettarlo? Oppure, diffidando delle sue buone intenzioni, riteniamo che sia stato “obbligato” da qualcosa o qualcuno a farci un favore? Certamente no…
In realtà, la nostra formula così singolare è l’unica a collocarsi, in maniera chiara, in quel terzo e più profondo livello di gratitudine di cui parla il Dottore Angelico, che evidentemente presuppone i due precedenti: ob-ligatus; si tratta di un vincolo, un dover retribuire.7
Quando diciamo «obrigado», dimostriamo al benefattore che il nostro apprezzamento per il bene che ci ha concesso è grande al punto da suscitare in noi l’obbligo di ricompensarlo in qualche modo. Non si tratta, però, di qualcosa di simile a un debito, ma piuttosto di una necessità di onore, che parte dal nostro cuore. In questo modo, la retribuzione diventa un «obbligo che si adempie spontaneamente».8
Per questo stesso motivo, aggiunge ancora San Tommaso,9 non è conveniente che sia immediato, perché chi si affretta a restituire non ha lo spirito di un uomo grato, ma quello di un debitore che non vede l’ora di vedersi libero dal debito. È meglio aspettare il momento opportuno.
Dobbiamo superare il bene che abbiamo ricevuto
Almeno sotto questo aspetto – forse uno dei pochi – possiamo dire che il portoghese e il giapponese sono molto simili. Anche l’attraente arigatô si riferisce al terzo e più alto grado di gratitudine, ma in un modo particolare.
Arigatô può significare: l’esistenza è difficile, è difficile vivere, rarità, eccellenza.10 Gli ultimi due significati sono facili da comprendere: in un mondo in cui la tendenza generale è che tutti pensino a se stessi, il ringraziare – atto così naturale e semplice – diventa raro e persino eccellente. Ma in che modo «l’esistenza è difficile» può essere collegata alla gratitudine?
Quando si parla di retribuzione, San Tommaso d’Aquino11 – giustamente – si mostra piuttosto esigente. Secondo lui, la ricompensa deve essere maggiore del beneficio ricevuto.
Ecco la ragione: una volta che siamo stati oggetto di un favore e, pertanto, di un ossequio gratuito, acquisiamo un vero e proprio obbligo a concedere anche noi qualcosa gratuitamente. Ora, se la retribuzione è inferiore al beneficio, il nostro “debito” d’onore non sarà “pagato”; se invece è uguale, avremo solo ripagato quanto abbiamo ricevuto. Pertanto, per ricambiare degnamente, si rende necessario superare il bene che ci è stato elargito.
Tuttavia, se a volte è difficile, o addirittura impossibile, anche solo eguagliare in merito il bene che ci è stato fatto, come possiamo superarlo? Ad esempio, non si potrà mai rendere a Dio – o anche ai propri genitori – tutto l’onore che Gli è dovuto per tutto ciò che abbiamo ricevuto. Si intende così il quanto «l’esistenza è difficile», il quanto «è difficile vivere», a partire dal momento in cui siamo stati oggetto di un beneficio e che ci mettiamo nella disposizione di ripagarlo di conseguenza.
Come uscire da questa situazione? Non sarebbe meglio non essere mai oggetto di una benevolenza, fuggire da ogni e qualsiasi benefattore, piuttosto che dover sopportare un fardello così pesante com’è la gratitudine? Se il lettore la pensa così, per favore si calmi: la soluzione è molto più semplice.
Gratitudine non è sinonimo di pagamento
In primo luogo, è necessario tener presente che il vero benefattore agisce in modo disinteressato, senza aspettarsi una retribuzione. Pertanto, fuggire per paura di diventare un eterno debitore, sarebbe come cercare di nascondersi dal sole a mezzanotte…
Il mondo di oggi, dove tutto è commercio, comprende molto poco la virtù della gratitudine. Per questo il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira lamenta che «la virtù della gratitudine sia intesa oggi in modo contabile. Così, se qualcuno mi fa un beneficio, io devo rispondere, in termini contabili, con una parte di gratitudine pari al beneficio ricevuto. C’è, pertanto, una sorta di pagamento: il favore si paga mediante l’affetto, così come la mercanzia si paga con il denaro. Quindi, io ho ricevuto un favore e devo estrarre dalla mia anima un sentimento di gratitudine».12
La vera retribuzione è molto più accessibile di quanto immaginiamo, perché il beneficio non si paga con oro o argento. Il tesoro da cui scaturisce la gratitudine è dentro di noi: il nostro cuore.
Il vero significato di questa virtù dimenticata
Per discorrere, dunque, sul vero volto di una virtù così nobile, passo ancora una volta la penna al Dott. Plinio, che lo ha spiegato con la precisione, la profondità e il tratto che lo contraddistinguono:
«La gratitudine è, in primo luogo, il riconoscimento del valore del beneficio ricevuto. In secondo luogo, è il riconoscimento del fatto che non meritiamo quel beneficio. E, in terzo luogo, è il desiderio di dedicarci a chi ci ha reso il servizio in proporzione al servizio prestato e, ancor più, alla dedizione dimostrata nei nostri confronti. Come diceva Santa Teresina, ‘amore si ripaga solo con amore’. O la persona paga dedizione con dedizione o non ha pagato».13

Messa nella Chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)
Una disputa tra dedizioni: questa è la virtù della gratitudine. Com’è bello e nobile essere emuli gli uni degli altri quando si tratta di affetto, benevolenza e dedizione. Secondo San Paolo, questo è l’unico debito degno di un cristiano: «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole» (Rm 13, 8).
Ora, in cosa consiste questa dedizione se non in quel vincolo così ben espresso nel nostro «muito obrigado» – ob-ligatus? Quanta profondità in parole così semplici! Pronunciarle è molto facile, ma metterle in pratica… In questo senso, possiamo dire con Mons. João Scognamiglio Clá Dias: «Quanto è rara la virtù della gratitudine! Spesso viene praticata solo attraverso l’educazione e le semplici parole. Tuttavia, per essere autentica, è necessario che trabocchi dal cuore con sincerità».14
Infine, consapevole dello sforzo che il lettore ha fatto per arrivare alla fine di questo articolo, non oserei chiuderlo in altro modo se non con un sincero e caloroso «muito obrigado»! ◊
Note
1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. II-II, q.107, a.2.
2 SAN TOMMASO D’AQUINO. De decem præceptis, a.1.
3 Cfr. SANT’AGOSTINO DI IPPONA. Sermo 283, n.2. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 1984, vol.XXV, p.96.
4 “Merci deriva da merces – salario – che nel latino popolare ha assunto il significato di prezzo, da cui è derivato quello di favore e quello di grazia” (LAUAND, Jean. “Obrigado”, Perdoe-me”: a Filosofia de São Tomás de Aquino subjacente à nossa linguagem do dia a dia. In: Hospitalidade. São Paulo. Anno XVI. N.2 [maggio-agosto 2019], p.142, nota 11).
5 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Como grandes voos de espírito. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno IV. N.43 (ottobre 2001), p.34.
6 SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE. Sermo 27, n.8. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 1988, vol.VI, p.232.
7 Cfr. LAUAND, op. cit., p.142.
8 SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit. q.106, a.1, ad 2.
9 Cfr. Idem, a.4.
10 Cfr. LAUAND, op. cit., p.142.
11 SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit. a.6.
12 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 1/6/1974.
13 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 27/12/1974.
14 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Dieci guarigioni e un miracolo. In: L’inedito sui Vangeli. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2012, v.VI, p.412.


